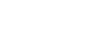MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
GLI INDIFFERENTI, Alberto Moravia - a cura di G. Zanello
Alberto Moravia, GLI INDIFFERENTI
ed. Bompiani, €13,00
“Entrò Carla”:la natura teatrale de “Gli indifferenti” è già tutta nell’incipit, nell’ingresso della ragazza, anzi della fanciulla, come sempre la definisce Moravia, nel salotto di casa sua, dove abiteremo per la maggior parte delle pagine del romanzo, con gli intervalli delle soste in sala da pranzo; anche la luce, come in un allestimento teatrale, viene ogni volta puntigliosamente descritta: piccole sfere luminose su ombre cupe in salotto, una bianchezza accecante in sala da pranzo. Le penombre del primo accompagnano situazioni torbide e false; la bianchezza della seconda si fa allegoria ora dell’accecamento ossessivo, ora della sperdutezza asettica e priva di slancio vitale, ora della tensione, sfociante in logoranti quanto vane discussioni, alla sincerità, alla chiarezza. Tensione sempre frustrata, destinata a naufragare prontamente nelle ombre del salotto. Come a teatro, l’azione è concentrata in un numero ridottissimo di ambienti, oltre a quelli già citati altri due salotti e un paio di camere da letto, tutti interni, con poche e fugaci eccezioni. Cinque i personaggi: Carla, suo fratello Michele, la madre, l’amico di famiglia, amante della madre e poi di Carla, Leo Merumeci, Lisa, ex- amante di Merumeci.“Entrò Carla: aveva indossato un vestitino di lanetta marrone (…) in piedi, presso il tavolino della lampada, cogli occhi rivolti verso quel cerchio di luce del paralume nel quale i gingilli e gli altri oggetti, a differenza dei loro compagni morti e inconsistenti sparsi nell’ombra del salotto, rivelavano tutti i loro colori e la loro solidità, elle provava col dito la testa mobile di una porcellana cinese…”: una lunga didascalia, potremmo dire, con l’indicazione dell’abito e della posizione del personaggio, oltre che degli oggetti di scena, una di quelle didascalie dettagliate che si trovano anche in Pirandello. E certamente Pirandello, citato nelle prime pagine, è un termine di confronto importante per capire “Gli indifferenti”, tanto più che lo stesso Moravia ebbe a dichiarare che la sua intenzione era quella di scrivere una tragedia. Della classica tragedia familiare, del resto, la trama ripete in modo esibito i temi: la passione ossessiva e divorante della madre, l’amante che ne seduce la figlia quasi sfiorando l’incesto, il fratello che ne viene informato da una vecchia amante sprezzata di cui la madre è però morbosamente e ciecamente gelosa, e che si sente chiamato alla vendetta. Ma la tragedia si rivela impossibile, come già nell’”Enrico IV” del drammaturgo siciliano. E forse il confronto può offrire ancora qualche spunto illuminante, anche sulle profonde differenze. La fine della tragedia, la sua incompatibilità con l’era moderna, era già stata teorizzata da Pirandello in una memorabile pagina de “Il fu Mattia Pascal”, dove Oreste si trasforma inesorabilmente in Amleto e non può più credere alla sua vendetta ma può solo recitarla, cosciente di non muoversi al cospetto del cosmo ma nell’angusto spazio di un teatrino nel quale il suo dolore è condannato allo strazio senza grandezza. E dunque Enrico IV sceglie di recitare, di preservarla, quella grandezza, tagliando ogni legame con la realtà, luogo non della verità ma della recitazione scadente, del tentativo di tenere insieme maschere di dignità destinate a logorarsi e a mostrare l’abietto disfacimento di chi le porta. Il gioco regge, ma solo fino a quando la realtà non gabba Enrico IV, forzandolo a varcare il diaframma della finzione, ad agire. A questo punto scatta anche per lui la condanna: la maschera non sarà più scelta, garanzia di uno spazio preservato di libertà, ma giogo imposto, come per tutti gli altri. Possiamo ancora notare come il personaggio pirandelliano riponga la sua speranza di sfuggire all’immiserimento dell’umano nel tenersi fuori dalla classe borghese, in ciò rispettando il vincolo tradizionale che vuole la tragedia riservata a personaggi “grandi”. Ebbene, Moravia al contrario immerge la sua narrazione nel mondo borghese. In un certo senso si potrebbe dire che i suoi protagonisti provengono dalle file dei personaggi secondari del dramma pirandelliano, alcuni conservandone la grottesca ottusità, altri, certamente Michele e a tratti anche Carla, come maturati al fuoco bruciante della consapevolezza, che li ha inceneriti. ” ‘… sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia’. ‘E’ quello che finirò per fare’ ella disse con una certa teatrale decisione, ma le pareva di recitare una parte falsa e ridicola”. “ ‘Tutto qui diviene comico, falso, non c’è sincerità… io non ero fatto per questa vita’ (…) Ebbe l’impressione di volgere le spalle non al salotto, ma ad un abisso vuoto e oscuro: ‘Non è questa la mia vita’, pensò ancora con convinzione; ‘ma allora?’ ”. Carla e Michele condensano in queste parole la disperazione che li opprime, dal fondo di un mondo falso. E questa disperazione non ha pertugi, non solo nel senso che non si ravvisano indizi di una vita autentica (se non nel pianto di una prostituta per la madre morta, che sbigottisce Michele come un fiore nel deserto) ma, ben più radicalmente, perché la stessa disperazione, appena da avvertita diviene consapevole, ha un suono di recita, di moneta falsa. I due ragazzi non s’illudono di trovare verità, neppure più la cercano; si accontenterebbero della sincerità, ovvero, abbandonata ogni ambizione circa la conoscenza della realtà, di un momento di coincidenza con sé stessi, di un atto, di un’emozione, vissuti senza vederli da fuori, che per ciò stesso si accreditino come veri, come punto di congiunzione con la vita. La tensione di Carla imbocca subito la via distruttiva: l’unica strada per cambiare è degradarsi, rovinarsi del tutto, completamente. E poi stare a vedere che cosa succede, in un mondo cui non si è avvezzi, di cui non si possiede in partenza la chiave. Michele, come sappiamo, imboccherà invece la via della tragedia: perdersi, non abbandonandosi senza controllo alla sorte, ma in un atto cui il parossismo delle offese ha fornito almeno quel poco di autentica ira che dà l’energia di apprestarlo. E quest’ira Michele coltiva, in lunghi soliloqui, soprattutto nella passeggiata solitaria nella quale decide l’acquisto della pistola e che ha qualcosa delle tormentose peregrinazioni del Raskol’nikov dostoevskiano. Ma ancora non basta. Quel tanto di sincero sdegno che la coscienza è riuscita a mettere insieme viene sconfitto dalle onde silenziose del gran mare incognito ad essa sottostante, e l’atto con cui il ragazzo doveva documentare a se stesso la possibilità di essere sincero si risolve in un atto mancato. Il sipario cala nel segno dello scacco e del ridicolo, mentre le scelte già ripiegano sugli abili mezzucci che permetteranno di salvaguardare la maschera borghese. Teatro, dunque, non come solo luogo possibile, benché insidiato, della verità, come in Pirandello, ma teatro come condanna, smarrita ogni possibilità di vita autentica. L’io non può strapparsi la maschera perché la scoperta che sotto la maschera non c’è nulla è già stata fatta, e da tempo, e il gesto non può più essere, nemmeno momentaneamente, liberatorio, ma solo falso. L’inconsistenza dell’io non deve più essere dimostrata attraverso dialoghi accanitamente raziocinanti: semplicemente si dà come esperienza. Se ne può rinvenire una spia anche lessicale, nel passo dei personaggi, sempre ‘malsicuro’, come la voce; negli occhi, per lo più ‘imbambolati’. La narrazione copre una manciata di giornate e di notti, in una Roma grigia e piovosa. La grande villa al centro dell’ambientazione e dell’intrigo giace nel silenzio di un quartiere lussuoso i cui abitanti non si intravvedono mai. Solitaria e grandiosa, costruita per incorniciare esponenti di una classe potente e in ascesa con le sue proporzioni prestigiose, la suppellettile raffinata, l’abbondanza di oggetti ornamentali, ospita al contrario un’umanità rattrappita e evanescente, che sembra sempre sul punto di perdersi nei lunghi corridoi, nelle ampie zone d’ombra. La villa, simbolo di status, è ormai di fatto perduta, nella declinante condizione economica degli attuali proprietari; con essa svanirebbe anche l’appartenenza di classe, evento questo che colma di terrore la madre, la cui vacillante identità è data ormai soltanto dalla routine di quella appartenenza; i giovani al contrario sono a tratti inclini a vedere nella rovina economica perfino un evento positivo, capace di portare vita nelle loro esistenze vuote e umbratili; neppure loro, però, sanno immaginare una strada diversa, sanno dove volgere lo sguardo per trovare indicazioni. E poi, oltre a non sapere, sembrano non saper desiderare davvero. Quella che li accompagna è una disperazione inerte, che ottunde anche il dolore; è l’indifferenza, appunto, che li fa proclivi ad accettare un compromesso, per quanto spregevole, atto a protrarre l’inerzia. Perché anche da loro non pare emergere identità al di fuori delle lunghe e ripetute sequenze di gesti convenzionali, ivi comprese quelle tristissime dedicate al sesso; al di fuori delle puntigliose e ripetute rassegne di abiti e oggetti: elencazioni ossessive e angosciose che, insieme alla sottolineatura insistita della convenzionalità banale, trasmettono il senso di una realtà che si sfalda , di cui occorre continuamente inventariare i lacerti, quasi per accertarsi della loro esistenza. Nell’atmosfera depressa e claustrofobica in cui i protagonisti nuotano come in un fluido ipnotico che li rallenta e li ammutolisce, la storia collettiva è inghiottita come dalla nebbia: scritto a partire dal 1925 e pubblicato nel 1929, quando l’autore aveva diciotto anni, il romanzo non contiene alcun accenno alla vita politica dell’Italia del tempo, se non vogliamo vederne uno nel classismo terrorizzato e sprezzante della madre. Ma in questo caso nulla meglio dell’assenza potrebbe illustrare la paralisi morale, insieme causa ed effetto della dittatura. La conclusione della vicenda, con il fallimento di ogni velleità di grandezza e la viltà del compromesso, non lascia spiragli, non lascia dubbi sul fatto che l’indifferenza abbia divorato anche il dolore. E tuttavia proprio la narrazione spoglia e ripetitiva, che rende impossibile ogni identificazione, ogni consolazione, permette di domandarsi se una simile chiarezza di sguardo si possa dare al di fuori di un paragone, di un confronto con un nocciolo di dignità etica, di coscienza di bene, nonostante tutto diverso dall’indifferenza e movente ultimo dell’autore. Perché se non c’è, ne ‘Gli indifferenti’, alcuni difesa esplicita di un qualsivoglia quadro valoriale, non c’è neppure traccia di critica dei valori, non c’è alcun entusiasmo demistificatorio. La ragione non ricava dalla sua vittoriosa scarnificazione di ogni fede né orgoglio né liberazione di energia vitale autodeterminantesi, solo desolata contemplazione di macerie , vergogna e ridicolo. Non ci sono basi per fondare la consistenza di un senso qualunque, ma l’assenza di senso non dà pace; inerzia, ottundimento, magari oblio, ma non pace. Se non si può parlare di dolore, per la ragioni che abbiamo cercato di dire, si può forse suggerire che l’assenza, scontata sul piano razionale, esistenzialmente non regga, slittando, almeno a tratti, nella mancanza. Il romanzo potrebbe così essere letto come banco di prova della tesi sostenuta di recente da Costantino Esposito ne ‘Il nichilismo del nostro tempo’: “per comprendere il momento storico che stiamo vivendo, segnato dall’ombra lunga del nichilismo, bisogna intercettare quei punti di luce in cui il vuoto di senso che finora appariva solo come una perdita di valori e di ideali si muta lentamente – ma inevitabilmente- nell’emergere di un bisogno. Proprio allora possiamo verificare se c’è qualcosa di irriducibile che ‘resista’ alla grande riduzione”. E’ un’ipotesi di lettura, che richiede certamente più attente verifiche, particolarmente nello scandaglio del punto di incontro, o di separazione, tra la dimensione psicologica e quella propriamente filosofica. Certo, Esposito parla del nostro tempo, e l’opera di Moravia ha quasi un secolo. E tuttavia l’ipotesi consente di recuperarne la forza di novità e di durata, ben oltre quanto consentito da una lettura più appiattita sul dato meramente socio- politico, come quella che le assegna la completa liquidazione del buon senso borghese.
A cura di:
Giuliana Zanello è nata a Milano nel 1957. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha insegnato al liceo classico di Busto Arsizio. Collabora occasionalmente con IlSussidiario.net