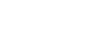MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
CONTAGIO: RILETTURA DI UN PERCORSO CANONICO, a cura di G. Zanello
CONTAGIO: RILETTURA DI UN PERCORSO CANONICO
a cura di Giuliana Zanello
La prima descrizione dettagliata di una pestilenza è quella che Tucidide dà della peste di Atene, scoppiata alla fine del primo anno della guerra del Peloponneso. In verità l’epidemia, con la sua terrificante velocità, si era già affacciata dai primi versi dell’Iliade; tuttavia, in un certo senso, la spiegazione narrativa del fenomeno (l’empia arroganza di Agamennone che offende Apollo nella persona di un suo sacerdote) e la sua rapida fine ne attenuano l’impatto, apparentandolo più alle tante stragi sul campo di battaglia che alla malattia: uomini sani e forti cadono quasi istantaneamente, colpiti dalla freccia del dio, cui neppure il guerriero più esperto può sfuggire; cadono, per così dire, senza avere il tempo di essere malati, senza mostrarci piaghe e sofferenze; cadono per una ragione precisa, per una colpa nota. Inoltre, ed è forse l’aspetto decisivo, dai versi omerici è assente, tra gli elementi che caratterizzano l’epidemia, quello che è forse il più spaventoso e ripugnante: il contagio.
Il contagio si accampa invece con la forza del vero protagonista nella fredda, oggettiva narrazione tucididea. Atene è in guerra, la regione intorno è in mano al nemico. Gli Ateniesi hanno però la loro splendida città, entro le cui Lunghe Mura hanno trovato tutti rifugio. E d’improvviso l’incubo, quando il rifugio diviene una gabbia in cui il morbo si aggira, rabbioso e silente, e le mura non difendono più dal male, perché esso è dentro. Non c’è, nel lucido sguardo dello storico, la ricerca di significati morali o religiosi, non c’è azione dalla quale guardandosi si può stornare o interrompere il flagello. Anzi, proprio ciò che era bene – la città sicura, in cui c’era posto per tutti- è divenuto la legna che alimenta l’incendio. Sulle cui origini si azzardano ipotesi ma non ci sono certezze. Il contagio, si diceva: a completare paradossalmente il rovesciamento del bene in male, la morte non viene da chi ti odia o è indifferente, ma da chi ti ama e ti è più vicino. Fin dall’inizio, fin dalla sua natura essenziale, il contagio è nemico della società degli uomini. E’ qui il suo orrore: non soltanto, come sempre capita al povero bene umano, la fedeltà agli affetti, la lealtà amicale non sono in grado di fermare il male, ma al contrario lo favoriscono. Al punto che l’egoismo e l’indifferenza possono apparire la sola salvezza. Apparenza del tutto ingannevole, ma sufficiente, insieme allo spettacolo della rovinosità dell’amore, ad erodere qualunque vincolo sociale e morale, mentre cedono, sotto la paura e l’oggettiva oltranza della realtà, i riti, i riti funebri in particolare, senza i quali non sappiamo che mai sia esistita società umana.
Gli Ateniesi fermati dalle parole di Tucidide nelle loro terribili sofferenze non sono eroi raggiunti dal loro destino, sono povera carne umana variamente martoriata da una molteplicità di sintomi puntigliosamente descritti, in preda a un male dai molti volti. E, insieme allo sbriciolarsi della società, questa fisicità dolorosa è anche la sostanza della rielaborazione di Lucrezio. Corpi ammalati, carne ferita abbandonata dall’intelligenza, oltre che dagli dei sul cui aiuto si ostinava a contare. Sappiamo come sia complessa la discussione sull’ultima parte del VI libro del De rerum natura, su quei versi per noi conclusivi che non è certo lo fossero per il poeta. Meglio che ciascuno tenga per sé le inevitabili suggestioni cui non può che soggiacere , in noi, il lettore ingenuo. Sappiamo che i versi del poeta latino sono il frutto di una retorica raffinatissima, di cui fa parte anche la crudezza con cui rielabora il già crudo Tucidide , del quale non poteva che amare, lui, il poeta dell’osservazione ‘scientifica’ dei fenomeni, l’analoga spassionata precisione.
Siamo carne fragile, questo gridano i versi lucreziani, e il morbo non è punizione di alcunché : la prospettiva religiosa di Omero è rovesciata e il contagio è solo una delle tante cause fisiche capaci di scardinare la provvisoria coesione degli atomi. Non c’è altro, e nulla lo dimostra meglio dei morti sorpresi dalla fine sui gradini dei templi. Un affresco pauroso e senza spiragli, pedagogicamente enfatico, perché l’uomo deve imparare quanto è misero per poter risalire. Risalire da sé, con la forza della sua mente, nonostante o contro un universo vuoto di provvidenza.
Virgilio non raccolse direttamente la sfida, trasferendo la strage, nelle Georgiche, al mondo degli animali innocenti. Ma resta, anche in questo passaggio, la sostanza quasi insopportabile del fatto, ovvero l’innocenza delle vittime. Se gli dei ci amano e hanno fatto il mondo per noi, diceva Lucrezio, cur anni tempora morbos apportant, quare mors immatura vagatur? In molti modi gli uomini fabbricano il male, proprio e degli altri, attraverso le mille forme dell’avidità, di piaceri, di ricchezze, di potere, sfiancandosi nel vizio, perdendosi nel mare per il guadagno, mandandone migliaia a morire in guerra in un solo giorno per il potere. A tutto questo il saggio si sforza di porre rimedio , per sé e per gli altri. Ma la radicalità della posizione lucreziana sta in questo, che nessuna via filosofica può essere intrapresa se, prima ancora della propria colpevolezza, non si accetta la propria innocenza, se non si comprende che la pretesa di essere puniti in quanto colpevoli, presupponendo che a qualcuno nell’universo importi di noi e delle nostre scelte, è precisamente la vera forma della superbia. C’è da compiere un passo più duro dell’accettazione della punizione, ed è l’accettazione dell’ innocenza, che ci getta nel vuoto.
Può non farlo? E’ umano, è razionale, è etico, non restare impietriti di fronte al miasma invisibile che ci annienta attraverso l’aria che respiriamo, usando malvagiamente dei nostri affetti, delle nostre amicizie, del nostro lavoro, delle cure che prestiamo ai malati?
La domanda è abissale e forse per questo, ogni volta, siamo incapaci di tenere gli occhi aperti fin dall’inizio. Il primo gesto è sempre quello di chi allontana da sé l’insopportabile. Così in Manzoni, così nel Ripamonti sua fonte, così ne La peste di Albert Camus. Perfino agli uomini che si trovarono a fronteggiare la peste del 1630, che pure avevano della pestilenza una memoria assai recente, i primi segni non parvero inequivocabili, non tali da costringerli ad accettare di trovarsi di nuovo di fronte alla tragedia. Sono monotone, le narrazioni delle pestilenze. Secolo dopo secolo si ripetono sempre le stesse fasi: i primi episodi strani, qualcuno che sussurra a bassa voce la parola impronunciabile, qualcun altro che nega recisamente, un primo caso chiarissimo, le prime provvidenze prese con cautela, le proteste contro misure che appaiono ingiustificate, dannose e di malaugurio, la fuga in avanti del morbo, la rincorsa affannosa nel dilagare del contagio.
Sia Manzoni sia Camus analizzano puntigliosamente tutti questi passaggi, indagando con precisione acuta ed appassionata i modi e le tappe con cui gli uomini allontanano da sé la resa all’ evidenza. E’ solo viltà, quella che ci fa ritrarre sgomenti dal prendere atto di ciò che abbiamo già capito? O è piuttosto l’invadenza della domanda di cui sopra, il suo piantare le tende nelle nostre vite con l’inesorabilità del nemico assediante? Non è forse la necessità di misurarci con la disperazione, o, piuttosto, di dare conto della nostra speranza?
Se si confronta il racconto, pur tristissimo, che Boccaccio ci ha lasciato delle peste fiorentina del 1348 con la narrazione manzoniana, non può sfuggire una marcata differenza di tono. Nella sua marcia inesorabile di morte e distruzione della socialità, nella sua erosione terrificante dei sentimenti di umanità e dell’etica, la peste del Decamerone appare ingabbiata fin dall’inizio in una interpretazione che in qualche modo la risolve. Il male è giusta punizione per le colpe umane e, in questo senso, ne è anche allegoria e rivelazione. Non ci sono dubbi sulle ragioni del tremendo castigo, anche perché la colpa stessa è sentita nella sua essenza collettiva, come propria dell’intera specie e , in particolare, della città colpita, che nell’epidemia pare , più che perdersi, portare precipitosamente alle estreme conseguenze un male morale già radicato.
Non così nei Promessi Sposi. Manzoni esamina e illustra quasi incredulo le cecità e gli errori di coloro che avrebbero potuto limitare la furia del contagio e non lo fecero. Dalle righe trapela l’ansia di chi si domanda se davvero il male sia inesorabile, di chi ha fiducia nell’umana capacità di contrastarlo e non può che sdegnarsi di fronte alla cecità volontaria. Siamo lontanissimi dalla giustificazione religiosa dell’epidemia come punizione meritata, nessuna risposta precostituita sparge unguento sulla piaga dell’umano limite, soprattutto del limite di chi avrebbe potuto e dovuto meglio provvedere. Qui non è in gioco il giudizio di Dio ma il giudizio dell’uomo, nella sua stolta buona fede, nei suoi autoinganni, infine nella perversione della ricerca del colpevole. Prima di mettere in campo la domanda fondamentale, Manzoni attende, e nulla come questa attesa ne rivela la sincerità e la forza. Meglio non sostituire alla sofferta cautela dello scrittore la nostra fretta. Rischiamo di ritrovarci in un batter d’occhi arruolati nel drappello degli amici di Giobbe di biblica e poco onorevole memoria. No, la fede che Manzoni mette alla prova, con verifica assidua, nel racconto del flagello, non prevede una Provvidenza che manda la peste, né un facile bene che da questa derivi. Battute o discorsi di questo genere sono di qualche personaggio, ma nulla ci autorizza ad accreditarle all’autore. Anzi, il provvidenzialismo consolatorio trova la sua satira più efficace, com’è noto, nella ‘scopa’ evocata da don Abbondio. Il Dio di Manzoni non manda la peste, ma nella peste non ci abbandona. Nessuna facile consolazione, dunque, ma la dolorosa figura di fra Cristoforo che accompagna, prima della propria fine, la fine di don Rodrigo, nell’attesa di una redenzione non garantita ma resa possibile da una presenza.
Solo questo riscatta il grande male e dà alla conclusione della pestilenza manzoniana quel senso di respiro largo e rinfrancato che manca, invece, nella conclusione dell’opera di Camus. Qui gli uomini riprendono a credersi liberi, mentre ‘nessuno sarà mai libero finché ci saranno i flagelli’. La riconquistata normalità non è che una pausa, finché la peste non risveglierà i suoi topi mandandoli a morire in una città felice. Di nuovo cancellando appuntamenti, affari, progetti, separando amanti, abolendo il futuro. E di nuovo gli uomini non crederanno al suo primo apparire, non ci crederanno neppure quando ci saranno già dentro, ma continueranno a sentirsi padroni della situazione, infiammando polemiche sui giornali. Fino all’apertura di ospedali speciali e al blocco di ogni spostamento, quando si ritroveranno prigionieri, costretti al corpo a corpo col contagio, presi tra i numeri della strage e i medici che, per un tempo di cui non vedono la fine, non hanno più il compito di curare ma quello di condannare. Soli nel silenzio delle strade deserte, calcinate dal sole.
Le tappe del contagio descritto da Camus non differiscono nella sostanza dal racconto manzoniano, ma il lettore oggi è preso alla gola dall’aderenza alla storia di questi giorni, fin nei dettagli, anche in forza della somiglianza di mentalità e stili di vita. Sbalorditi come noi, gli abitanti di Orano, di trovarsi di fronte a un flagello che pensavano archiviato nella notte dei tempi…
Il protagonista del libro di Camus, il dottor Rieux, appare tristemente lucido fin dai primi passi dell’epidemia. Osserva con razionale distacco ma anche con umana pietà il dibattersi dei suoi concittadini, nell’inutile sforzo di sottrarsi all’evidenza. Registra il naufragio degli ‘umanisti’, ovvero di coloro che si erano fino ad allora illusi che ai fatti importasse qualcosa dei loro gusti e delle loro opinioni. Non ha, dal canto suo, prospettive di felicità o salvezza, né personali né religiose o filosofiche, tuttavia non è intaccato dalla disperazione. Il dottor Rieux è l’eroe della certezza morale, l’uomo che , nella circostanza, si domanda quale sia il suo compito e ad esso non si sottrae. Infaticabile organizzatore di tutto ciò che occorre per far fronte all’epidemia, il dottore coagula intorno a sé anche alcuni conoscenti, disparati per levatura, passato, convinzioni, destini. Trovano in questo un riscatto? L’asciuttezza antiretorica di Camus ne tace, mentre le vicende individuali sono funeste o ambivalenti. Resta la dedizione, restano i gesti compiuti per un giudizio, solo perché giusti.
Tutti conosciamo questi testi perché nella scuola italiana si leggono tutti. Chi insegna Italiano li legge tutti gli anni, anche quest’anno. Ho letto le pagine di Tucidide in una prima , nel mese di dicembre. Un ragazzino, impressionato, mi ha chiesto se ci fosse ancora la peste. Risento ancora la mia risposta: c’è, ma non scoppieranno più simili epidemie perché abbiamo gli antibiotici e i vaccini. Ho letto e fatto leggere questi testi per anni e anni. Ma li avevo capiti?
A cura di:
Giuliana Zanello è nata a Milano nel 1957. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore e insegna al liceo classico di Busto Arsizio. Collabora occasionalmente con IlSussidiario.net