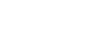MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
La città nella letteratura del '900 italiano. Prelievi antologici, di Giuliana Zanello
LA CITTA' NELLA LETTERATURA DEL '900 ITALIANO. PRELIEVI ANTOLOGICI
Federigo Tozzi scrive Con gli occhi chiusi nel 1913. Incominciamo da qui, da quando il secolo muove i primi passi, un viaggio nelle città italiane attraverso gli occhi degli scrittori. E’ un viaggio assai parziale, di poche tappe, sufficiente però, si spera, a scoprire la ricchezza del nostro novecento letterario sotto questo aspetto particolare, invogliando ad ampliare l’indagine e a sondare anche per altri versi la tenuta delle opere narrative nella loro capacità di fissare un dato di realtà e di farcelo vedere per la prima volta, o farcelo vedere meglio. Anche quando non è l’argomento principale.
E’ un viaggio nella geografia e insieme, inevitabilmente, nella storia: l’antologia quasi parla da sola e il mero succedersi delle date delle prime uscite costruisce spontaneamente la storia e il destino della città, nel nostro paese, sul filo del XX secolo.
Torniamo dunque a Tozzi, a un fermo immagine di Siena colto quando si è ormai a due passi dal primo conflitto mondiale:
Non due tetti della stessa altezza, anche se accanto. Grumoli grandi e piccoli di case che s’allungano parallelamente obliqui e storti: alcune volte le case stanno a due e tre angoli l’uno dentro l’altro, a cerchio, a nodi, serrate insieme, mescolate, aggrovigliate, con curve rotte o schiacciate, sempre con improvvisi cambiamenti; obbedendo alle forme delle colline, ai pendii e alle svolte delle vie, alle piazze che dall’alto paiono buche.
Ad un tratto, uno stacco tra due case, e poi le altre che s’afferrano e si tengono ancora, con forza, pigiandosi e abbassandosi e poi risalendo e girando per sparire leste leste dietro quelle che hanno un movimento affatto diseguale e che vengono incontro dalla parte opposta; salite su; ma anche queste s’interrompono quasi subito per doventare una raggiera più larga, irregolare, tutta piana oppure contorta; dentro la quale si mettono e s’avventano case, di sghembo, a traverso, come riescono e possono; spinte da altre che fanno l’effetto di volersi accomodare meglio ed assestarsi, ciascuna per conto proprio.
Le case, bassissime, quasi per affondare nella campagna, da Porta Ovile, da Fontebranda, da Tufi, sorreggono quelle che hanno a ridosso, le trattengono dalla loro voglia di sparpagliarsi più rade; i punti più alti sono come richiami alle case costrette ad obbedire per non restare troppo sole.
Nei rialzi sembra che ci sia un parapiglia a mulinello, negli abbassamenti le case precipitano l’una addosso all’altra; come frane. Oppure si possono contare fino a dieci file di tetti, lunghe lunghe, sempre più alte; di fianco, altre file che vanno in senso perpendicolare alle prime.
La Torre del Mangia esce fuori placida da tutto quell’arruffio.
Nessuna presenza umana, le case stesse ne fanno le veci, trascinate in un progressivo parossismo di moto, tra lo slancio e la fuga. Il paesaggio, in realtà del tutto immobile, si agita in una frenesia di affanno e angoscia, tra vortici e frane, tra prossimità bramata e insopportabile soffocamento, in perfetta corrispondenza con la vicenda psicologica del giovane protagonista del romanzo. Descrizione modernissima, nella sua furia visionaria, dalla quale, tuttavia, Siena balza fuori come direttamente dagli affreschi del trecento. Tanto che, della modernità, non reca neppure la traccia del compiacimento estetico per le sopravvivenze del passato: preindustriale e preturistica, la città è totalmente nel presente, indenne da nostalgie museali.
Non molto diversa, in questo, dalla Firenze del ventennio fascista che riempie di sé Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini:
Ha cantato il gallo del Nesi carbonaio, si è spenta la lanterna dell’Albergo Cervia. Il passaggio della vettura che riconduce i tranvieri del turno di notte ha fatto sussultare Oreste parrucchiere che dorme nella bottega di via dei Leoni, cinquanta metri da via del Corno. Domani, giorno di mercato, il suo primo cliente sarà il fattore di Calenzano che ogni venerdì mattina si presenta con la barba di una settimana. Sulla Torre di Arnolfo il marzocco rivolto verso oriente garantisce il bel tempo. Nel vicolo dietro Palazzo Vecchio i gatti disfanno i fagotti dell’immondizia. Le case sono così a ridosso che la luce lunare sfiora appena le finestre degli ultimi piani. Ma il gallo del Nesi, ch’è in terrazza, l’ha vista ed ha cantato.
Dalla Siena di Tozzi sono passati più di trent’anni (il romanzo di Pratolini esce nel 1947), carri e cavalli arretrano di fronte a tram e motociclette, ma garanzia della vita sempreverde della città non è tanto questo; lo sono piuttosto i gatti che frugano nell’immondizia dietro Palazzo Vecchio, a due passi da via del Corno e dai suoi inquilini sempre in bilico sulla voragine della miseria, non di rado già con un piede o due nell’illegalità. La città vive, pullula, ribolle di tutti i livelli e le situazioni della condizione umana, la sua bellezza secolare è un abbraccio che tutto accoglie, non ancora una vetrina da tenere lucida con severi e giudicanti criteri di decoro. Nel cuore di Firenze, là dove oggi la gente normale non può nemmeno sognarsi di abitare, c’è posto per l’umanità rumorosa e derelitta, e perfino per un gallo.
Assenti sia il turismo sia il concetto di città d’arte, come si vede ancor meglio facendo un rapido confronto con la Ferrara di Bassani:
Sul momento uno può anche non accorgersene. Ma basta star seduti per non più di qualche minuto ad un tavolino all’aperto del Caffè della Borsa, avendo dinanzi la rupe a picco, d’un rosso quasi dolomitico, della Torre dell’Orologio, e, appena più a destra, la terrazza merlata dell’Aranciera, perché la cosa salti subito all’occhio. Si tratta di questo: d’estate come d’inverno, col sole o con la pioggia, è molto raro che chi ha da passare lungo quel tratto di corso Roma, anziché infilarsi sotto il basso portichetto dove nella penombra, accresciuta durante i mesi più caldi dal grosso tendone esterno, si annidano gli antri contigui del Caffè della Borsa e dell’antica farmacia Barilari, preferisca tenersi al marciapiede di fronte, lungheggiante in linea retta e in piena luce la bruna spalletta della Fossa del Castello. Se qualcuno lo fa, potrà essere il turista con l’indice infilato fra le pagine della scarlatta Guida del Touring, assorto, il naso all’aria, nella contemplazione delle incombenti quattro torri del castello Estense, potrà essere il viaggiatore di commercio che, la bosa di pelle sottobraccio, corre via trafelato verso la stazione ferroviaria, potrà essere il contadino della Bassa venuto in città per il mercato, il quale, in attesa della corriera pomeridiana di Comacchi o di Codigoro, porta attorno con evidente imbarazzo il proprio corpo reso pesante dal cibo e dal vino da lui ingurgitati poco dopo mezzogiorno in qualche bettola di San Romano… Potrà essere chiunque, insomma, ma non certo un ferrarese.
Una notte del ’43, il racconto di cui si offrono queste poche righe, è compreso in Cinque storie ferraresi, scritto nel ’55 e ambientato nei primi anni del dopoguerra. La Ferrara di Bassani è città d’arte: la raffinatezza architettonica e urbanistica dell’antica capitale degli Estensi è presente nello sguardo e nel sentire dello scrittore ad ogni pagina, nelle Storie ferraresi come nel Giardino dei Finzi Contini, dove pure fa la sua comparsa la Guida rossa del Touring. Il turista è ormai parte del paesaggio cittadino, un turista colto e sensibile al bello, nel caso di Bassani; qui importa registrare, oltre alla certificazione del cambiamento sopraggiunto nel costume generale e nella vita economica delle antiche città, quanto di comune vi sia tra lo sguardo del visitatore e quello dello scrittore che, qui e altrove, nello splendido e commosso affresco delle bellezze di Ferrara lascia avvertire, come un basso continuo, una nota funebre, un senso nostalgico di fine, mentre il passato, col suo splendore di oro brunito, pone in doloroso risalto la mediocrità provinciale, cattiva abbastanza da provocare tragedie, meschina e ipocrita abbastanza da privarle di ogni grandezza. La borghesia di provincia ha tremendi motivi di imbarazzo, in quel dopoguerra in cui sono ancora presenti dappertutto i segni delle sue peggiori connivenze; ma il più imbarazzato è il popolano, in questo caso un abitante di quel contado che per secoli era stato con la città in naturale simbiosi, che ormai è ben più straniero del turista. Qualcosa si è rotto nell’equilibrio che costituiva l’essenza della vita cittadina, nella compresenza di grandezza e miseria che impediva alla prima di cadere nella leziosaggine o nella musealità e alla seconda nella disumanità. Le antiche pietre, anche quando consentono ancora la coabitazione, non bastano a ridurre fratture deflagranti.
Anna Maria Ortese, Il mare non bagna Napoli,1953:
Mi trovavo davanti alla Banca d’Italia, poco prima dell’Augusteo, nel tratto che va dal grosso edificio della Banca fino a piazza Trieste e Trento, passando davanti alla Galleria Umberto e al Vico Rotto San Carlo. Qui finiva (o cominciava) la celebre via Roma, già Toledo, dal nome del viceré Don Pedro, che la fece aprire nel 1536 sul fosso ovest della cinta aragonese. Quasi rettilinea, in lenta salita da sud a nord, lunga due chilometri e 250 metri, come avvertono le guide, è l’arteria principale della città. Stendhal la definì “la via più gaia e più popolosa dell’universo”, e suppongo che questa fama le sia rimasta.
Come già la sera precedente nel rione di Chiaia, e benché non fosse ancora la medesima ora, anche qui c’era un gran movimento, un che di eccitato e straordinario, come fosse accaduto qualcosa – un assassinio, un matrimonio, una vincita, la fuga di due cavalli, una visione -, ma poi, accostandosi, era nulla. La plebe dall’informe faccia riempiva questa strada meravigliosa e scendeva dai vicoli circostanti e s’affacciava a tutte le finestre, mischiandosi alla folla borghese, come un’acqua nera, fetida, scaturita da un buco nel suolo, correrebbe ingrandendosi, su un terrazzo ornato di fiori. Della presenza di questa plebe, non era nessun segno sulle facce dei borghesi, eppure essa era una cosa terribile. Non è che vi fossero solo due o tre vecchie madri, di quelle che si grattano il capo, trascinando uno zoccolo, coi grandi occhi rotti dalle memorie, ma ve n’erano cento, duecento. Non è a dire che gli uomini dal petto concavo e gli occhi loschi, le mani strette al petto, fossero cinque o sei, ma erano per lo meno mille. E se aveste cercato una sola di quelle ragazze imputridite, che ornano le finestre dei vicoli con le loro fronti gialle, e cantano e ridono sommessamente, in maniera un po’ tetra, sareste stato abbondantemente appagato. La passeggiata n’era piena. Se poi aveste voluto incontrare, per pregarlo di una commissione, o solo guardarlo in faccia, uno di quei ragazzetti fra i cinque e i dieci anni, che commerciano in sorelle e tabacco con gli Americani, quando la flotta USA è nel porto, sareste rimasto atterrito dalla loro quantità. Essi pavimentavano, addirittura, con le loro grigie carni, la strada. E come al cospetto appariva mirabile e strana la serenità dei borghesi! Io mi dissi che due cose dovevano essere accadute, molto tempo fa: o la plebe, aprendosi come la montagna, aveva vomitato quella gente più fina, che, allo stesso modo di una cosa naturale, non aveva occhi per l’altra cosa naturale; o questa categoria di uomini, per altro motivo ristretta, aveva rinunciato, per salvarsi, a considerare come vivente, e facente parte di sé, la plebe. Forse, scaturite ambedue queste forze dalla natura, non era mai sorta in esse la possibilità di considerare una rivolta alle sue sante leggi.
Quante fratture, nelle parole della Ortese! La prima, evidentissima, tra la città monumentale, quella che era stata per secoli la capitale dell’unico regno sul suolo italiano, e il presente, in cui i monumenti sono il fondale di una civitas che si è perduta: anche il turismo, qui, appartiene al passato, si ferma a Stendhal, all’Italia preunitaria. La seconda, tragicamente sottolineata, tra borghesia e plebe. Plebe, non popolo; poveri che non sanno nemmeno immaginare una condizione diversa dalla marginalità, un daffare diverso dal cercare grama sopravvivenza alla corte del padrone di turno, attraverso servigi degradanti o miserabili loschi commerci. Il peggio della miseria che sopravvive a spese del peggio della ricchezza. La seconda guerra mondiale, con la traumatica esperienza dell’occupazione, sembra avere fossilizzato le separazioni, blindando il degrado. A questo sottoproletariato napoletano non resta dignità, non bellezza, non salute; solo una cieca, imperscrutabile, inarrestabile forza di moltiplicarsi. Dall’altra parte, un’indifferenza tanto completa e serena da essere inquietante: indifferenti “per salvarsi”, dice la Ortese dei borghesi. Da che cosa? Da quale paura? Di una rivolta? Improbabile: gli altri, gli ignorati, ignorano a loro volta, non pensano a contrapporsi, presi nella loro affaccendata esistenza parallela. Dalla paura della caduta? Forse – è questa l’eterna paura borghese. Più probabilmente, da quella dell’assalto della realtà, che costringerebbe, in primo luogo, a buttare all’aria il fragile fortilizio in cui sono accomodati; con quali esiti? Solo di diventare peggiori, a propria volta indecenti. Questa è la paura. E’ anche il pensiero della scrittrice? Ha inventariato, in questa e in tante altre pagine, la condizione umana più disperata, senza sottrarsi al suo urto, senza cercare linimenti, per ammonire a guardarsene? Evidentemente no. L’indifferenza dei migliori non ha nulla di olimpico, ha piuttosto la precarietà artificiosa e sinistra della maschera, è a sua volta esito di una frattura, di un cataclisma ancestrale e, se non si vuole che alla fine soffochi il vivente che apparentemente protegge, è necessario combatterla.
In ogni caso, colpisce come l’inarrestabile proliferazione organica della plebe napoletana sia, nelle parole della Ortese, del tutto esente da vitalità, si sottragga a qualunque idealizzazione della condizione “naturale”, “primitiva”; colpisce anche come tutto il male sia nell’uomo, sull’uomo ricadendo, senza toccare la solenne bellezza di strade e piazze.
Questo rapporto appare rovesciato nel quasi contemporaneo Ragazzi di vita di Pasolini, del 1955:
(…)da Monteverde giù alla stazione di Trastevere non si sentiva che un solo continuo rumore di macchine. Si sentivano i clacson e i motori che sprangavano su per le salite e le curve, empiendo la periferia già bruciata dal sole della prima mattina con un rombo assordante. (…) Tutta Roma era un solo rombo: solo lì su in alto, c’era silenzio, ma era carico come una mina. (…) Da Monteverde Vecchio ai Granatieri la strada è corta: basta passare il Prato e tagliare tra le palazzine in costruzione intorno al viale dei Quattro Venti: valanghe d’immondezza, case non ancora finite e già in rovina, grandi sterri fangosi, scarpate piene di zozzeria. Via Abate Ugone era a due passi. La folla giù dalle stradine quiete e asfaltate di Monteverde Vecchio, scendeva tutta in direzione dei Grattacieli: già si vedevano anche i camion, colonne senza fine, miste a camionette. Motociclette, autoblinde. (…) Il Riccetto abitava alle scuole elementari Giorgio Franceschi. Venendo su dalla strada del Ponte Bianco, che a destra ha una scarpata con in alto le case di Monteverde Vecchio, si vede prima a sinistra, affossato nella sua valletta, il Ferrobedò, poi s’arriva a Donna Olimpia, detta pure i Grattacieli. E il primo edificio a destra, arrivando, sono le scuole. Sull’asfalto slabbrato s’alza una facciata più slabbrata ancora, con al centro una fila di colonne quadrate bianche e agli angoli quattro costruzioni massicce, come torrioni, alte due o tre piani.(…) Marcello, invece, abitava ai Grattacieli un po’ più avanti: grandi come catene di montagne, con migliaia di finestre, in fila, in cerchi, in diagonali, sulle strade, sui cortili, sulle scalette, a nord, a sud, in pieno sole, in ombra, chiuse o spalancate, vuote o sventolanti di bucati, silenziose o piene della caciara delle donne o delle lagne dei ragazzini. Tutt’intorno si stendevano ancora prati abbandonati, pieni di gobbe e monticelli, zeppi di creature che giocavano coi zinalini sporchi di moccio o mezzi nudi.
La Roma monumentale è cancellata, nemmeno proposta per contrasto. Essa non ha nulla a che vedere con il Riccetto, respinto in una specie di girone infernale sconvolto e sconquassato, perduta ogni armonia, della città come della natura. Il paesaggio lunare ed estremo, tra gli sterrati fangosi, le scarpate, le discariche, il trionfalismo di certe costruzioni del ventennio già fatiscenti, i falansteri spersonalizzanti della metropoli moderna, le baracche di fortuna, è il correlativo oggettivo di un momento di profonda trasformazione culturale e sociale. Potrebbe essere una distruzione creatrice, ma Pasolini sembra piuttosto incline a dirci che si tratta di una creazione distruttrice, un’anticreazione che, sottratte le sue vittime a cultura e natura, le lascia alla deriva presso lo scoglio delle Sirene: canto delle Sirene è il rombo dei motori che il Riccetto ode nelle prime righe, canto della nuova società fatta di consumi, da cui l’umanità del ragazzo finirà stritolata. Tutta contemporanea, dunque, la Roma di Pasolini, colta nel momento in cui rinnova urbanisticamente se stessa e rinnova membra; e questo rinnovamento ha bisogno dell’espulsione della parte più povera della popolazione. E’ bene notare, tuttavia, che, pur nella durezza dell’analisi dei rivolgimenti socio-culturali in corso, nella descrizione pasoliniana non troviamo traccia di ripiegamento nostalgico, di rimpianto estetico; certo perché, come si è detto, il punto di vista adottato è quello del giovane protagonista, con il risultato, tuttavia, di uno slancio combattivo, di un’adesione al cimento posto dal momento storico, che distanzia enormemente la critica sferzante di Pasolini dal cupo scoramento della Ortese.
Commista di vecchio e nuovo, spesso in spaesante contrasto oltre che in caotica sovrapposizione, è anche la Milano di Alberto Savinio in Ascolto il tuo cuore città, completato prima della guerra ma stampato solo nel ’43, quando all’urto del rinnovamento urbanistico si univa il dolore per distruzioni provocate da ben altro che l’entusiasmo modernista del decennio precedente:
E’ sera e io cammino sul filo dei miei ricordi, ma la traccia a poco a poco impallidisce e muore. Dove mi trovo? L’ala sinistra del Palazzo reale è cinta da uno steccato come da una benda enorme, oltre a questa si apre uno spazio immenso non d’altro pieno che di tenebre, nel quale i miei ricordi annaspano per un po’ e poi annegano, come dentro un lago che la notte mi teneva celato. Milano in questo periodo di trasformazione è come una città colpita qua e là da distruzioni immani, in mezzo alle quali sorgono già, come viluppi di nuvole dalla bocca di un cratere, gruppi massicci di costruzioni nuove.(…) Il faro che orienta il mio faticoso andare è l’alto edificio dell’albergo Plaza, che come torre sorge, corrusco di luci e di scritte pubblicitarie, su questa intenebrata terra di nessuno. Traversato l’oscuro ‘lago’ arrivo nella “città nuova”. Città dura. Città di ferro. Enormi palazzi si serrano in gruppo, uniscono le rigorose file delle loro finestre prive di persiane – i loro occhi senza ciglia- si danno la mano attraverso archi massicci, pesano con tutti i loro dodici piani sui portici che li sorreggono di sotto, e che stanno zampe plumbee e quadrate nella positura di mostruose scolopendre raggelate. Lanterne enormi pendono tra pilastro e pilastro, e su questi marmi lustri, su questi negozi bianchi che ancora non hanno calore di vita, non attività di commerci, su queste vetrine vuote spandono una luce metallica e fredda. I portoni, chi sa perché? Rammentano il trionfo di Radames. Carri armati dell’edilizia. E’ soltanto un’impressione? I passanti sono suggestionati dai ricordi, e stentano a prendere contatto con queste case nuove. Ma passerà. Tutto passa.
Il destino di questo testo ha voluto che tutto l’apparato metaforico adottato al momento della stesura si fosse avverato in tragica lettera all’atto della pubblicazione; la sovrapposizione è inevitabile e fu integrata nell’opera dallo stesso Savinio in un’apposita, dolente, nota conclusiva. Ma, accantonando per un momento la dimensione involontariamente profetica, rileggiamo quelle metafore per quello che erano al momento della stesura, quando l’autore era di fronte, in tempo di pace, al vorticoso mutamento della città. Savinio pennella la nostalgia con distacco ironico, non permette ai sentimenti (pur sottolineati con dolcezza comprensiva) di tradursi in opposizione al nuovo, avvertito come necessità storica e potenzialmente positivo. Se lo sguardo rimane per momento ferito da voragini e demolizioni, se il viandante si ferma smarrito, venuti meno i suoi punti di riferimento, il tono complessivo risulta in definitiva fiducioso, analogo a quello di tanti quadri futuristi. Gli uomini stentano a prendere contatto con le cose nuove, ma il nuovo è il loro destino perché “tutto passa”. E’ la distruzione creatrice. E tuttavia le scelte lessicali dicono anche altro, di questo inevitabile nuovo registrando la violenza. “Città dura. Città di ferro”, “Carri armati dell’edilizia”. La guerra, di cui il Futurismo aveva tessuto l’elogio e che nella realtà storica non c’era ancora, stava nascendo dalle viscere stesse della città, era già presente nella violenza dell’urbanistica. E anche attraverso la guerra la distruzione creatrice avrebbe continuato e accelerato la sua marcia.
Luciano Bianciardi pubblica La vita agra nel 1962. Milano è ormai tra le città emblema del pieno tumultuoso ingresso dell’Italia nell’era dell’industria. Che crea benessere (o almeno minore miseria), ma accelera i processi di marginalizzazione ed espulsione. Quando il protagonista del romanzo di Bianciardi, intellettuale comunista approdato a Milano dalla Toscana, si mette a cercare nella metropoli industriale quella classe operaia con cui era in contatto al suo paese e che sapeva qui tanto più numerosa, fa una curiosa scoperta:
Franz il triestino a volte mi favoleggiava di operai grandi e grossi, che limano la ghisa con le mani, da quanto le hanno callose, ma non era facile vederli, almeno per me che entravo in redazione alle nove e ne uscivo alle sette di sera. Gli operai limatori di ghisa con le mani arrivavano infatti ogni mattina alle sei coi treni del sonno, mangiavano bivaccando in fabbrica, e ripartivano con gli stessi treni prima delle sei, ogni sera così. (…) Alle cinque cominciano a entrare i primi treni in stazione, e a buttar giù battaglioni di gente grigia, con gli occhi gonfi, in marcia spalla a spalla verso il tram, che li scarica all’altro capo della città dove sono le fabbriche. Per due, tre minuti, sotto le volte della sala biglietti sfilano a passi lesti, poi tutto ritorna vuoto e silenzioso, fino al prossimo treno, al prossimo sbarco di gente assonnata e frettolosa. Non puoi fermarne uno, chiedergli come si chiama, che cosa fa, se è vero che lima la ghisa con le mani, come dice Franz il triestino. Li guardi e sono già sfilati via senza voltare gli occhi attorno. E anche più fretta hanno la sera, perché c’è la paura di perdere il treno, un treno qualunque sempre disponibile perché tu lo perda, e poi ti tocca aspettare mezz’ora il prossimo, ed è mezz’ora sottratta al sonno. Anche se dall’orologio è chiaro che non ce la faranno, gli uomini grigi e intabarrati, con una sciarpa di lana al collo, o il passamontagna calato sugli occhi, non rallentano la marcia verso la banchina dei treni, e continuano ad arrancare anche quando il convoglio si è messo in moto, e gli vanno dietro ostinati e febbrili.
La distruzione creatrice prosegue la sua marcia e, alla marginalizzazione realizzata dal sempre più rapido spostamento delle genti meccaniche dai quartieri storici alle enormi periferie, accosta un altro tipo di marginalità, raccogliendo, come una gigantesca rete da pesca, la popolazione dei borghi circostanti che, grazie alle opportune infrastrutture di trasporto, non ha alcun bisogno di integrare, sottraendola però nel contempo, oltre che a se stessa, ai paesi e alle cittadine di residenza, trasformate in breve in poco più che dormitori. Tuttavia, al di fuori della visionarietà degli scrittori, nella vita di tutti i giorni, i miglioramenti c’erano, graduali, magari piccoli, ma incontestabili, nelle retribuzioni, nelle garanzie, nei diritti; soprattutto, nella percezione comune, l’industria era ancora il domani, un domani che si prevedeva lungo, tanto da dare il tempo di adattarsi, come diceva Savinio, ma anche di umanizzarlo. Invece, non passarono nemmeno vent’anni. Paolo Volponi, Le mosche del capitale, uscito nel 1989, ambientato nel 1980:
La grande città industriale riempie la notte di febbraio senza luna, tre ore prima dell’alba. Dormono tutti o quasi, e anche coloro che sono svegli giacciono smemorati e persi: fermi uomini animali edifici; perfino le vie i quartieri i prati in fondo, le ultime periferie ancora fuori della città, i campi agricoli intorno ai fossati e alle sponde del fiume; anche il fiume da quella parte è invisibile, coperto dalla notte se non dal sonno. Buie anche le grandi antenne delle radiocomunicazioni e dei radar della collina. E’ un rumore del sonno quello di un tram notturno che striscia tra gli edifici del centro. Gli uomini le famiglie i custodi i soldati le guardie gli ufficiali gli studenti dormono, ma dormono anche gli operai: e non si sentono nemmeno quelli dei turni di notte, nemmeno quelli dei turni di guardia di ronda tra le schiere dei reparti o sotto le volte dei magazzini. Quasi tutti dormono sotto l’effetto del Valium, del Tavor e del Roipnol.
Ma dormono anche gli impianti, i forni, le condutture, dormono i nastri trasportatori delle scale mobili che depositano le pozioni chimiche nelle vasche della verniciatura o nei lavelli delle tempere. Dorme la stazione ferroviaria, dormono anche le farmacie notturne, le porte e le anticamere del pronto soccorso, dormono le banche: gli sportelli le scrivanie i cassetti le poste pneumatiche le grandi casseforti i locali blindati; dormono l’oro l’argento i titoli industriali; dormono le cambiali i certificati mobiliari i buoni del tesoro. Dormono i garzoni con le mani sul grembiule o dentro i sacchi di segatura. Dormono le prostitute i ladri gli sfruttatori le bande organizzate, i sardi e i calabresi; dormono i preti i poeti gli editori i giornalisti, dormono gli intellettuali; quanto caffè, alcool, fumo tra quelle ore. E mentre tutti dormono il valore aumenta, si accumula secondo per secondo all’aperto o dentro gli edifici.
Dormono i calcolatori, ma non perdono il conto nei loro programmi.
La memoria è sospinta immediatamente verso il celeberrimo notturno di Alcmane: "Dormono le cime dei monti e le gole, i picchi e i dirupi, e le schiere di animali, quanti nutre la nera terra, e le fiere abitatrici dei monti e la stirpe delle api e i mostri negli abissi del mare purpureo; dormono le schiere degli uccelli dalle ali distese", soprattutto nelle traduzioni più libere che hanno moltiplicato l’anafora di “dormono”. Senza azzardare ipotesi sulla legittimità filologica dell’accostamento, lo usiamo in quanto utile per noi, certificando, in un passo dall’indubitabile valenza lirica, la profonda assimilazione della modernità, i cui elementi, fino ai più umili oggetti, esauriscono quasi interamente il repertorio delle immagini, respingendo in una lontananza remota il paesaggio naturale, ignorato anche a livello metaforico (diversamente da quanto avviene ancora, ad esempio, nel passo di Savinio). In compenso anche qui, come già in Tozzi, gli umani manufatti si antropomorfizzano, con la differenza capitale che qui gli oggetti non sono latori di rimandi simbolici agli uomini, ma sono agli uomini mescolati, sullo stesso piano. Il sonno universale da cui la città è sommersa appare anche come un’estensione del sonno dei pendolari di Bianciardi: tutti, tutti dormono, anche coloro che la società giudica molto svegli, anche coloro che dovrebbero avere vigile coscienza, come i poeti, i preti, gli editori, i giornalisti. Tutti apparentemente acuti nell’analisi del cammino della società che si ritiene “industriale”, tutti in realtà addormentati, tanto profondamente da non sentire che quel sonno generale ha un rumore. E’ il rumore di una nuova distruzione che avanza con il ronzio dei terminali, quella svolta finanziaria che sta già trasformando le fabbriche in musei e consegnando al declino le grandi città industriali. E’ quanto osserva Massimo Raffaeli nella prefazione all’edizione Einaudi: “Il romanzo comincia dove finisce Papà Goriot, ma dall’alto della collina non c’è Rastignac a sfidare Parigi, nei cui traffici si scontrano i capitani dell’industria e del commercio, gli eroi di una cultura totalmente secolarizzata. Sotto la collina da cui Bruto Saraccini, al colmo di una notte insonne, scruta un secolo e mezzo più tardi il panorama della grande città di Bovino (evidentemente Torino) si squaderna invece un paesaggio postindustriale. E’ una notte del 1980, nel cui silenzio Saraccini coglie un fragore che resiste al sonno e sopravvive alla fatica diurna, ed è qualcosa che trascende la somma dei profitti d’impresa, del guadagno commerciale o del salario convenuto alla massa degli addetti: quel rumore dilagante è nel flusso del valore di scambio che muove i terminali dei calcolatori (…) e riassume a somma zero la totalità della giornata. (…) annuncia la completa mercificazione del lavoro, lo spirito di impresa si riduce ai tabulati della partita doppia.” Il valore di scambio e la partita doppia sono da allora i soli urbanisti: è il valore di mercato delle case a determinare i caratteri della città, con gli esiti che sappiamo e che l’anno della pandemia ha messo sotto gli occhi anche di chi non ci aveva mai pensato. Sottratte le presenze temporanee o occasionali -pendolari, studenti, turisti-, chi e quanti sono i cittadini? Esistono ancora? O sono avviate, anche le nostre città, alla sorte di certi quartieri di Londra per ultraricchi, nei quali i proprietari risiedono una settimana all’anno al massimo, trasformandoli in inquietanti città fantasma? Il futuro ce lo dirà. Intanto concludiamo ancora con Savinio, per rendere omaggio alla sua chiaroveggenza profetica:
Questi edifici blindati, queste casematte io le conosco: le “riconosco”. Dove ho vedute le loro simili? A Roma, a Torino, persino a Napoli. Chi sa? Un giorno, tra poco, le nostre città si riconosceranno come si riconoscono i gemelli, per qualche segno che li distingue l’uno dall’altro: San Pietro distinguerà Roma da Milano, il Vesuvio distinguerà Napoli da Torino.
Bibliografia
Federigo Tozzi, Con gli occhi chiusi, 1913
Vasco Pratolini, Cronache di poveri amanti, 1947
Giorgio Bassani, Cinque storie ferraresi, Una notte del ’43,1956
Anna Maria Ortese, Il mare non bagna Napoli, 1953
Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita, 1955
Alberto Savinio, Ascolto il tuo cuore, città, 1943
Luciano Bianciardi, La vita agra, 1962
Paolo Volponi, Le mosche del capitale, 1989
A cura di:
Giuliana Zanello è nata a Milano nel 1957. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore e insegna al liceo classico di Busto Arsizio. Collabora occasionalmente con IlSussidiario.net