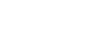MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
I PROMESSI SPOSI ALLA PROVA, G. Testori - a cura di G. Zanello
Autore: Giovanni Testori
I PROMESSI SPOSI ALLA PROVA
in OPERE/3
ed. Bompiani, 2013, pp 2167, € 59,00
Un gran silenzio, in quel silenzio la parola si fa carne, ossa, realtà. La parola che si incarna non è forse il senso stesso del teatro? Perché si dovrà pure tornare alla divina, umile, gloriosa, sacra, urlante, soffocata… ma poi redenta parola! Così- la citazione è solo un poco approssimativa- Franco Parenti arringava da par suo pubblico e attori nell’allestimento della stagione 1983/84 dei Promessi sposi alla prova. Siamo alle prime battute e il regista-maestro sta addestrando gli attori, quasi tutti alle prime armi, a realizzare il coro con cui intende aprire lo spettacolo: il coro, ‘forma prima dell’azione scenica’, nella quale la parola deve incarnarsi per rendere teatro la ‘gran tragedia’ manzoniana.
L’opera di Testori si erge come un monte massiccio e impervio, che nulla fa per invitare il viandante; solo salite faticose e stroncanti, cadute precipiti e laceranti promette e poi consente a chi vi si avventuri. La luce ne scaturisce, ma sempre attraverso il dolore dell’abbagliamento, e sempre dal profondo dell’immersione nelle grotte più oscure e abbandonate, là dove la vita non è mai assente – ciò implicherebbe una condizione sterile, ovvero disinfettata, che allo scrittore lombardo è del tutto estranea- ma al contrario presentissima nella sua concrezione originaria di umori, odori, poltiglia; utero in cui la carne si fa, tomba in cui la carne si disfa. Il monte è infinitamente stratificato, essendo il suo presente compresenza urlante di mille passati, feriti, distrutti, marciti, ma mai aboliti, sempre lì a reclamare la propria persistenza, a dire la propria parola. Una pressione enorme esercitata sulla lingua, che si incrina e si spacca, lasciando vedere un prima, lasciando colare il basso terragno sul tessuto del sublime, smentendo – o scaldando- con la concretezza perentoria del lessico il volo astraente dell’architettura sintattica; ma anche pressione della memoria culturale, là dove memoria non è evasione in un altrove ma perenne ripresentarsi, dietro le linee apparentemente tutte diverse del fenomeno presente, del dramma irrisolto. Non c’è idea che possa contenere il dolore sempre nuovo e sempre antico, ogni idea ha qualcosa di meno e dunque di insultante, quando pretenda di risolverlo, di tappargli la bocca. E allora riesplode l’urlo, costantemente veicolato dalla concretezza, dalla carne, con una oltranza espressiva, con un eccesso emotivo, con una iperbole che sembrano raccogliere tutta l’insopportabile mescolanza della vita.
Di questo monte non si pretende qui che di costeggiare le falde, a partire dall’opera forse più abbordabile. Al momento introvabile nel volumetto degli Oscar Mondadori in cui uscì insieme al suo presupposto, La monaca di Monza, è contenuta nel volume terzo delle Opere, edito da Bompiani, a cura di Fulvio Panzeri, con frammenti critici di Giovanni Raboni; la si può inoltre fruire sul canale youtube nell’allestimento di Andrée Ruth Shammah con protagonista Franco Parenti. A questo spettacolo faremo riferimento, accogliendone anche, all’occasione, qualche discrepanza rispetto al testo pubblicato; ricordiamo che, peraltro, il commosso commento di Raboni, nel volume citato, fa seguito alla nuova messa in scena del 1994, per la stessa regista. Quanto al dramma del 1967, La monaca di Monza, scritto da Testori per e su richiesta di Lilla Brignone, è attualmente reperibile nel secondo volume delle Opere.
Su una scena quasi del tutto spoglia, un gruppo di attori prova la rappresentazione di una riduzione teatrale dei Promessi sposi. Ma la parola ‘riduzione’ va subito corretta. Come si può parlare di riduzione, quando l’ambizione è quella di ‘dare carne’ al testo di partenza? Allora parliamo di nascita, di nascita del testo al teatro, di scommessa sulla sua possibilità di vita. Sulla possibilità di vita di quella che, già lo si è detto, viene qualificata come una ‘gran tragedia’. Con Testori non si può che andare lenti, non c’è parola su cui si possa correre lasciandosi alle spalle parte del suo spessore. E quelle che la necessità pratica della comunicazione ci ha costretto ad usare fin qui sono già talmente spesse da avere detto tutto.
A incominciare dalla ‘prova’. Si tratta certamente, a un primo livello, della situazione in cui gli attori provano lo spettacolo; e l’idea di metterla direttamente in scena rende inevitabile almeno il riferimento a Pirandello e ai ‘Sei personaggi in cerca d’autore’; solo che se là, in Pirandello, le dolenti figure erano portatrici di lacerti bisognosi di ricomporsi in una storia, una storia lineare da vivere una volta, come tutte le storie, perché possa passare, qui, in Testori, la storia c’è e va disfatta, scavata, disarticolata, per arrivare a ciò che non passa. La sua possibilità di essere viva sta appunto in questo, nel poterne strappare ciò che sopravvive alla linearità dello svolgimento – all’ineluttabile precipitare nel passato delle cose umane. Cogliamo così un altro livello della ‘prova’, quello che riguarda Manzoni e la messa alla prova del suo romanzo. Alla prova di che cosa? Dell’oggi, del regista, degli attori, degli spettatori, secondo un movimento individuato da Giovanni Raboni per la Trilogia degli scarrozzanti: Manzoni- Testori- Ognuno; Cristoforo-Testori-Ognuno; Gertrude- Testori-Ognuno, e così via. Ma prima ancora, e già lo si è anticipato, alla prova del teatro, ovvero della possibilità della parola di farsi carne.
Come si può tentare di riassumere, dunque, il rapporto con Manzoni? Partiamo dalla definizione di ‘gran tragedia’ con cui Testori qualifica il romanzo. Il grande milanese dell’ottocento era stato poeta tragico e, come tutti sanno, nella tragedia aveva reintrodotto il coro. Quel coro che per Testori è la forma prima dell’azione scenica. Se è vero che in Manzoni il coro è l’angolo dell’autore, il momento in cui questi esce dall’animo dei suoi personaggi per offrire allo spettatore il proprio sguardo, il proprio giudizio, e dunque, da questo punto di vista, rappresenta un ‘io’ e non un ‘noi’, è anche vero, però, che proprio nei cori Manzoni può far saltare le mura del genere tragico, arruolando all’interno della vicenda abitata dai ‘grandi’ coloro che gli statuti letterari impongono di escludere, i dappoco, gli anonimi, gli sconfitti. Ed è impossibile negare che nei cori dell’Adelchi, la tragedia contemporanea al romanzo, la poesia di Manzoni si faccia popolare, nel senso che vi compaiono il popolo minuto e oppresso e, in Ermengarda, tutte le donne che non fanno la storia ma la storia calpesta, le irrilevanti che i rilevanti non lasciano in pace, braccandole e distruggendole. ( E se proviamo a pensare per immagini, Ermengarda morente di dolore per l’amore perduto nel chiuso di un convento palesa qualcosa di affine con la monaca per forza del romanzo. Qualcosa, quel tanto di suggestione – la non amata chiusa in convento- che serve a dare maggiore spessore, non a consentire troppe deduzioni). In ogni caso, da quel coro che nelle tragedie di Manzoni rappresenta il bisogno di aprire, di sfondare i limiti dell’io, per quanto grande, e di giungere al ‘noi’, da quel coro che in Manzoni rappresenta il limite estremo del teatro, la soglia che supererà per abbandonarlo, Testori riparte, per ritornarvi dal romanzo.
La storia che Manzoni aveva reso coerente, ordinata ed equilibrata attraverso tre faticatissime stesure che l’avevano via via sottratta alla mescolanza- di generi, di toni, di lingua- viene disfatta e scavata per recuperare tutti gli eccessi e gli assurdi, quelli che l’autore via via scartò, quelli che l’autore mai osò. Insomma, semplificando molto, se in Manzoni la carne , di rado innocente e fiorita, per lo più fetida e malvagia, della storia, attraverso la luce della ragione e la speranza della fede si fa verbo, in Testori l’imperativo è tornare dal verbo alla carne. Perché la materia, tutta la materia del grande romanzo, compresa la geografia dei luoghi, la città, i paesetti, il lago, i fiumi, è viva e cocente, ma la pagina deve essere penetrata e quasi violata da qualcuno che quella vita ancora veda, ancora in sé senta, per strapparla all’insignificanza cui abbiamo consegnato la parola.
Saliente ed esemplare è il trattamento riservato alla figura di Marianna De Leyva, suor Gertrude, cui lo scrittore novatese aveva già dedicato il dramma del 1967. Gertrude sale dal basso, attraverso una botola, uscendo dalla cantina in cui è stata murata. Una cantina che è anche un pollaio, il pollaio in cui era stato rinchiuso il corpo della conversa Caterina di Meda, la Medasca, uccisa da da Egidio. Perché il delitto non passa mai e la testa tagliata di Caterina, come quella di Egidio, decapitato al termine della sua inutile fuga, occupa, invisibile, la scena, come la mente della Signora. Gertrude non è pentita, non potrebbe esserlo all’altezza delle vicende del romanzo; tuttavia la botola da cui emerge evoca potentemente, insieme alla cella in cui anni dopo sarà murata, l’abisso in cui l’omicidio ha precipitato la sua mente, ossessivamente ritornante alla ‘pulera’ dove sono i resti di Caterina. Gertrude non è pentita ma scaglia in faccia a tutti il suo dolore di figlia non amata, la sua libertà negata fin dalla nascita, l’orribile colpa dei suoi genitori che appare come generatrice anche della sua. Non c’è pentimento: viste le condizioni create dalla proterva volontà altrui, l’omicidio si è reso necessario per poter vivere l’amore, cioè per poter vivere tout court; ma la vita, l’adorabile vita, sanguina e gronda di male.
E’ il male, con la sua insopportabile onnipresenza, con il suo insondabile mistero, il vero protagonista della tragedia. Insolubile, come alla tragedia si richiede. Il male che, alla fine, uscendo dalle viscere della terra, scendendo dai monti come l’acqua, dentro l’acqua, imbevendo ogni zolla, arriva a invadere Milano. E’ la peste, manifestazione carnale di ogni male morale ma anche di ogni dolore, colpevole o innocente. In ogni assassino pulsa un grumo di dolore di fronte a cui dobbiamo ammutolire, portare rispetto; anche perché, a impedirci di considerare il grande male collettivo giusta punizione si erge il dolore innocente. Che è un appello senza consolazione. Infatti, quando siamo alle ultime battute del dramma e, tornata Gertrude nella sua botola e sconfitto dalle peste don Rodrigo, agli sposi non resterebbe che festeggiare le nozze, la botola si apre di nuovo. Dal buio, questa volta della tomba, Gertrude esce di nuovo, ma questa volta lei, proprio lei, la colpevole, interpreta il suo opposto, la madre di Cecilia. Il suo opposto, certo, almeno nell’interpretazione corrente, risalente del resto a prima di Manzoni, per cui la madre di Cecilia è l’icona della cristiana rassegnazione. Che cosa ci vuole dire, che cosa ricordare o rivelare, Testori, con questa scandalosa identificazione? in un memorabile assolo, la madre di Cecilia- Gertrude proclama la sua intenzione di restare lì per sempre, con un fantoccio in braccio a rappresentare la bambina morta, a ricordare l’inspiegabilità, lo scandalo del dolore innocente: ‘Io e lei, solamente. Io e Cecilia. Qui. Immobili. A giudizio di tutte le pesti e di tutte le loro sostituzioni che verranno’.
Una sorta di colonna infame alla rovescia, un pugno contro il cielo, la condanna preventiva di qualunque riduzione moralistica del dramma del vivere. Renzo e Lucia potranno festeggiare, ma solo se vissuta alla presenza di quella tragica icona la festa non sarà blasfema. Ma allora? Che cosa resta da festeggiare? E’l’ultima domanda posta da una smarrita Lucia, cui il regista risponde: la speranza. E questa parola sembra in crudo contrasto con quanto visto e sentito fin lì, tanto da far provare la tentazione di respingerla come conclusione un po’ posticcia, come ritorno repentino dalla tragedia al romanzo. Bisogna però ricordare che la speranza non è l’illusione, che la speranza è una virtù e come tale richiede forza, e forza sperimentata: la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza, a dire di San Paolo. Pertanto, provvisoriamente, con qualche residuo dubbio, bisognoso di approfondimento, sulla coerenza testoriana dell’ultima battuta, possiamo concludere con l’inno d’amore dell’autore per la sua città, così tormentato, così nostro: “Città insana, città sigillo, città cesta dove riposeremo un giorno la nostra stanca testa; io ti saluto: strade, case, piazze, asili, fabbriche mai finite, strade dalla peste circuite, città ospedale, oh vale, sì vale essere figli tuoi, anche qui e ora; l’afa di morte sale, ma tu, stranita, vuota, morta, città scorta, città porta, adoprati e accetta che sia questa prova il sì che veramente ti rinnova”.
Questa prova, appunto. Ritorna la parola del titolo, a dire che il contenuto della speranza è proprio questo, che il dolore sia una prova. E’ una conclusione convincente? E’ sufficiente? Forse no. Forse lo era di più l’ultimo grido di suor Virginia ne La monaca di Monza:
“Tutto sta per finire. L’ultima possibilità che ci resta è qui, in questo momento, in questa parola. Te la grido per me e per tutti quelli che furono e saran vivi. Guardaci. Punta i tuoi occhi su questi stracci che ti bestemmiano, su questo niente che ti reclama. Te lo chiediamo con lo strazio delle nostre ossa e delle nostre carni finite. Liberaci dalla nostra carne; liberaci dal nostro sangue; liberaci dalla nostra morte. O distruggiti anche tu nella nostra carne, nel nostro sangue e nella nostra morte. Ci senti? E allora, liberaci, Cristo! Liberaci!”
A cura di:
Giuliana Zanello è nata a Milano nel 1957. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha insegnato al liceo classico di Busto Arsizio. Collabora occasionalmente con IlSussidiario.net