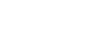MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
THE WASTE LAND (1), T. S. Eliot - a cura di Marco Grampa
T. S. Eliot:
Una breve visita tra immagini infrante.
The waste land (I).
La pubblicazione di The Waste Land risale a un secolo fa. Numerosi sono stati gli articoli a ricordarlo, anche sugli inserti letterari dei principali quotidiani. Sul web si trovano facilmente ampi commenti e recensioni sull’autore e la sua produzione letteraria. Qui non voglio aggiungere nulla, se non una piccola esperienza personale di lettura.
La lunga poesia in questione, quasi un poemetto, è stata pubblicata per la prima volta nel 1922. L’autore aveva già pubblicato alcune poesie, tra cui l’indimenticabile The Love Song of Alfred J. Prufrock, dove già si notava il superamento di uno snervato tardo romanticismo in favore di uno sguardo impietoso sulla realtà dell’uomo e del suo ambiente. Un Prufrock ormai avviato verso la mezza età, che si muove, indeciso, incapace, nella penombra di un mondo imbrattato da cartacce e gusci di molluschi e di frutta secca. In un linguaggio non immediato ma potente e suggestivo, direi inequivocabilmente diretto, moderno.
La poesia in questione porta la dedica a E. Pound, indicato come “miglior fabbro”, in quanto Pound suggerì di eliminare alcune parti, di snellire. In questo modo la composizione appare come una sequenza di brani, di segmenti apparentemente slegati che fanno pensare alle immagini frammentate del cubismo. Il mio suggerimento è quello di leggerla e rileggerla proprio come si farebbe visitando la sala di una galleria d’arte. Anche qui ogni opera, pur se dello stesso autore o periodo, è in sé completa e parte allo stesso tempo di un percorso. Si ammira un quadro, magari si ritorna sul precedente, poi lo si riguarda notando cose nuove. “Visitiamo” dunque questi brani il cui tema comune è certamente quello della desolazione, di un’ ombra di morte e dissoluzione. Il poeta ci partecipa la sofferenza che vede e alla fine invoca la pace, Shantih.
La poesia è ricca di riferimenti letterari, con citazioni da Dante a Baudelaire, dalla letteratura religiosa dell’India. Riferimenti anche ai miti classici della morte e della rigenerazione. Pensiamo all’aprile dell’inizio, del primo segmento. L’aprile gioioso di Chaucer, che apre all’estate e all’avventura del viaggio è qui ribaltato, e diventa il mese del risveglio della natura che disturba la quiete di un sonnolento riposo invernale dove ogni speranza di vita era seppellita nella dimenticanza ma nulla era di disturbo, quasi un “lascia che il tuo servo se ne vada in pace”, ma senza la certezza del luogo dove andare.
Pensiamo ancora alla massa degli impiegati e degli operai che lasciano uffici e fabbriche per tornare a casa e che il poeta paragona agli ignavi di Dante,
Città irreale,
Sotto la nebbia bruna di un’alba invernale,
Una gran folla fluiva sopra il London Bridge, così tanta
Ch’io non avrei mai creduto che morte tanta n’avesse
Disfatta.
Sospiri, brevi e infrequenti, se ne esalavano,
E ognuno procedeva con gli occhi fissi ai piedi.”
Ci sono memorie di letture dell’infanzia, forse di esperienze infantili, ma ormai lontane e perse, non più utilizzabili per decifrare l’oggi. L’immagine della slitta che scivola sulla neve, quella della passeggiata sul lago bavarese sembrano tratte da un quadro impressionista. Ben più cupo il dialogo tra le due donne al pub, quasi un realismo da quadro di Millet. Qui volteggiano gli avvoltoi della guerra finita da poco. Che dolore quel dialogo di due donne del popolo, (il linguaggio è lì a dircelo). Lei è stanca della vita dura del periodo postbellico, stanca con i suoi cinque figli, e non ha più la voglia o il coraggio di concedersi al marito, appena rientrato dalla guerra, per paura di restare di nuovo incinta. Ecco un altro segno della terra desolata, neppure il rapporto d’amore è salvo. Quel rapporto d’amore che non ha più nulla di amoroso e affettuoso e che troviamo nel “quadro” che ha come protagonista la dattilografa. Quel verso, “sono contenta che sia finita”, buttato lì dopo una scena d’amore segna un vertice di sterilità e desolazione.
“Stasera ho i nervi a pezzi. A pezzi, sì. Resta con me,
parlami, Perché non parli mai? Parla.
A cosa stai pensando? Pensando a cosa? A cosa?
Non lo so mai a cosa stai pensando.”
Sono le parole che una donna, (borghese?), rivolge al marito, al compagno, e prosegue, “Sei vivo o no? Non hai niente nella testa?
I versi fanno pensare a certe coppie dipinte da Hopper, come Stanza di New York.
E ancora, quello che sembra essere l’ambiente dove la donna vive,
“Un bosco enorme, sottomarino nutrito di rame
Bruciava verde e arancio…
Alla luce del fuoco, sotto la spazzola i suoi capelli
Si piegavano in punte di fuoco,
splendevano in parole, per ricadere in una calma cupa.”
Come non pensare qui a Franz Marc e agli espressionisti?
Proseguendo nella lettura, il poeta sembra poi spiccare il volo e guardare la terra dall’alto, scoprendone tutta la sua aridità. Aridità dei luoghi, la Londra postbellica, quindi in qualche modo l’Europa, e aridità dell’uomo.
“Se vi fosse acqua
E niente roccia
Se vi fosse roccia
E anche acqua
E acqua
Una sorgente
Una pozza fra la roccia
Se soltanto vi fosse suono d’acqua”.
Fino alla ripresa di alcune citazione dal libro sacro indiano, datta, damyata, shantih, cioè dare, condividere, e soprattutto pace. Pace, la parola che chiude la poesia.
Per una lettura in traduzione, www.daneel59.altervista.org/terradesolata.htm
Per l’originale, www.online-literature.com
A cura di:
Marco Grampa
Laurea in Lingue e Letterature moderne presso IULM di Milano. Insegnante al Liceo Classico Crespi di Busto Arsizio per 20 anni, per otto anni presso il Liceo Scientifico Tirinnanzi di Legnano, dove ha operato come senior manager per scambi culturali con istituti australiani, portoghesi e USA.
Traduttore di opere soprattutto di carattere letterario da paesi di lingua inglese, in particolare africani.
Autore di racconti e brevi saggi per riviste locali.