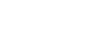MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
L'ULTIMO CAPITOLO INEDITO DELLA FAMIGLIA MUSHKAT, I. B. Singer, a cura di G. Zanello
L'ULTIMO CAPITOLO INEDITO DE LA FAMIGLIA MUSHKAT
di Isaac B. Singer
Ed. Feltrinelli, novembre 2013
pp. 104, € 7,65
16 OTTOBRE 1943
di Giacomo Debenedetti, ed. Sellerio, non disponibile
“Il Messia arriverà presto” (…) “Che cosa vuoi dire?” “La morte è il Messia. Questa è la verità.” Con queste amare parole, pronunciate in una Varsavia che esplode sotto le bombe naziste, si chiude La famiglia Moskat di Isaac Bashevis Singer, nella traduzione in inglese. Ed esse si impongono come le parole più adatte al buio del momento storico che inghiotte i protagonisti della lunga vicenda, portando con sé l’intero ebraismo orientale: un mondo, un popolo, una lingua, una sterminata letteratura, una grande parte di Europa. La fine di tutto come unico vero contenuto dell’attesa, un’attesa lunga millenni che ha plasmato quel popolo fin nelle viscere, il cui oggetto, coincidente con il senso del mondo, si svela come la legge della distruzione. E quante volte ripetiamo, o siamo tentati di ripetere, lo stesso concetto, in multiformi formule, davanti al crollo, spaventoso e assurdo, di quanto si è costruito? Davanti allo svanire, anonimo, crudele e insensato, di migliaia di vite tutte in mucchio, di quelle vite di cui abbiamo proclamato e argomentato appassionatamente l’unicità?
Eppure questa conclusione, così calzante nel suo disperato nichilismo e per quanto avallata dall’autore, non è la vera conclusione: nella versione originale, in yiddish, segue un ultimo capitolo, tagliato per volere dell’editore in ragione della corposità del romanzo, giudicata eccessiva. Una decina di pagine, nel corso delle quali la narrazione si sposta dai bagliori sanguigni di Varsavia ai boschi attraversati da un gruppetto di giovani ebrei in fuga, dalla fine di tutto al nuovo esodo: “Lontana era la terra degli ebrei. Chiuso era il deserto. Nessuna colonna di nuvola indicava il cammino di giorno. Nessuna colonna di fuoco illuminava la notte. Dio aveva nascosto il volto. Giacobbe era abbattuto. Lo schernivano i suoi nemici: dov’è il tuo Dio, Israele? Com’è che tace il tuo protettore?” (…) “Mosè è morto. Ma la sua parola vi chiama: alzatevi, resto d’Israele, preparatevi all’ultima battaglia. Perché è una fiamma la casa d’Israele e la casa di Esaù è paglia. Alzatevi e niente timore. Sta dalla vostra parte l’ultima vittoria. Per voi verrà messia”. Ecco, dieci pagine nelle quali Singer racconta una tragica notte di capodanno ebraico in cui pochi ebrei rimasti, cercandosi quasi a tentoni in mezzo al buio e alle macerie, si radunano per celebrare, tra le lacrime ma con inconcussa fede, i riti prescritti, e infine mette in scena un piccolissimo ‘resto’, in grazia del quale si rovescia la conclusione del capitolo precedente, sgorga ancora dai cuori l’attesa, e ‘messia’ non è morte ma vita.
Il capolavoro del minore dei due Singer fu pubblicato in versione integrale, in yiddish, prima a New York, nel 1950, poi a Tel Aviv, ma le traduzioni in altre lingue, compresa la nostra, dipendono dalla versione inglese. Per il lettore italiano l’ultimo capitolo, inedito nel resto del mondo, è stato dissotterrato da Erri De Luca, che l’ha tradotto dall’yiddish e pubblicato presso Feltrinelli nel 2013. Un libriccino che contiene, oltre al testo di cui stiamo parlando, la traduzione di un racconto dell’altro Singer, Israel.
Emigrato in America, orbato di gran parte della sua famiglia, Isaac Singer scrive in yiddish: una lingua scomparsa come correlativo di un mondo scomparso, come codice adeguato al congedo da un’epoca e da una comunità. Ma nello stesso tempo questa scelta è un nuovo atto di fede: le tenebre non prevarranno. E in questa fede, non nei mondani trionfi e ad onta di qualunque mondano scacco, sta la vittoria, così che -scrive Erri De Luca- “messia non è più il blasfemo sospiro del finale di capitolo 64, ma di nuovo la più potente energia di salvezza prestata alla storia umana. Così uno scrittore in fondo al suo narrare redime il redentore”.
La tensione religiosa abita ogni riga del testo di Singer così come ogni fibra di quel mondo, del resto non idealizzato ma rappresentato nella sua umana miseria; a meno che non se ne voglia interpretare in senso idealizzante proprio la pervicace, continua autocritica: il mondo dell’ebraismo orientale che sullo studio delle scritture e sull’osservanza ha costruito una cultura del tutto originale. In esso la fede, la sua possibilità, il suo sbriciolarsi nel confronto con la cultura europea secolarizzata, l’impossibilità di continuare ad aderire alla vita, una volta che la fede sia perduta, sono il perno su cui ruota l’esistenza. Da questo mondo, il quartiere ebraico di Roma, come emerge dalle pagine di 16 ottobre 1943, di Giacomo Debenedetti, appare lontanissimo. I tanti minuti personaggi che compaiono in questa quarantina di paginette, pur appartenenti alla più antica comunità della diaspora, citata già in Orazio e che conservava allora nella sua biblioteca testi favolosamente antichi, appaiono normalmente romani, italiani come tutti gli altri. Il polo opposto, si può dire, rispetto a una comunità separata, nettamente distinta. Sono cittadini come tutti, al punto che “il furto dei libri (perpetrato dai nazisti pochi giorni prima della tragica retata, ndr.) non era un’angheria per la gente del Ghetto, che di libri non si intendeva”. Gente che, come tutti gli italiani del resto, di occupazioni e dominazioni ne ha viste tante e pensa (come tutti gli altri ma più di tutti gli altri, in forza della maggiore consuetudine con la persecuzione) che, come ogni volta, si tratti di venire a patti col padrone di turno, di pagare per appagarne l’ingordigia e rispettare le sue ingiunzioni. Come sempre, come tutti, quando gli stivali di nuovi dominatori arrivano a pestare il tuo suolo. Ebrei assimilati, dunque, gli ebrei romani, al polo opposto, si può dire, delle comunità orientali. E così fino all’ultimo non si agitarono. Si seppe, sì, che diversi ebrei erano stati arrestati, ma in quanto antifascisti, si disse. “L’attività era stata colpita in loro, non la razza. I tedeschi continuavano a mostrarsi discreti, quasi umani. Con la loro forza così schiacciante, con la loro autorità così assoluta, avrebbero potuto fare assai di peggio.” “E gli ebrei dormivano nei loro letti verso la mezzanotte del venerdì 15 ottobre, allorché…”Allorché cominciò, tra lo sbigottimento generale, l’operazione che portò alla morte più di mille ebrei romani, molti dei quali si sarebbero potuti forse salvare, se avessero compreso che qualcun altro stava assegnando alla loro appartenenza ebraica, a quella appartenenza che per molti era poco più che anagrafica, un’importanza spropositata e inconcepibile.
È il caso di sottolinearlo: a cominciare la loro discesa agli inferi, quella mattina, furono più di mille romani. Romani da tempo inenarrabile, romani da molto più tempo di molti altri. E romani poveri, per lo più, semplici popolani. Comunque italiani, tanto radicalmente italiani che Debenedetti poté aprire la sua breve tesa cronaca con una scena che è stata giustamente paragonata all’incipit della manzoniana Storia della colonna infame:
“Giungeva invece nell’ex-Ghetto di Roma, la sera di quel venerdì 15 ottobre, una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia. Non può esprimersi, l’agitazione le ingorga le parole, le fa una bava sulla bocca. E’ venuta da Trastevere di corsa. Poco fa, da una signora presso la quale va a mezzo servizio, ha veduto la moglie di un carabiniere, e questa le ha detto che il marito, il carabiniere ha veduto un tedesco, e questo tedesco aveva in mano una lista di 200 capi di famiglia ebrei, da portar via con tutte le famiglie.” Non le credettero. “Se fossi una signora mi credereste. Ma perché non ho una lira, perché porto questi stracci…”
Anche in questo, italiani come tutti gli altri: non si dà credito alle parole di un poveraccio.
Ma bastano poche ore a scavare tra questi italiani comuni e il resto del mondo un abisso tanto inconcepibile quanto definitivo, a cui le vittime presto si arrendono: “Già sui visi e negli atteggiamenti di questi ebrei, più forte ancora che la sofferenza, si è impressa la rassegnazione. Pare che quell’atroce, repentina sorpresa già non li stupisca più. Qualche cosa in loro si ricorda di avi mai conosciuti, che erano andati con lo stesso passo, cacciati da aguzzini come questi, verso le deportazioni, la schiavitù, i supplizi, i roghi.”
Nella prefazione all’edizione Sellerio, Alberto Moravia nota come Debenedetti, non narratore ma critico, e critico di cultura decadente-estetizzante, si sia qui spogliato del suo raffinato intellettualismo per adottare procedimenti classici della letteratura italiana, il realismo nutrito di riflessione morale di Manzoni, da un lato, la tecnica della narrazione corale, dall’altro. E proprio sul senso di questa coralità l’autore de Gli indifferenti, anch’egli del resto toccato da quella tragedia, chiude la sua prefazione: “Debenedetti, sia pure attraverso la riscoperta del procedimento classico della coralità, ha toccato in queste pagine il vero punto dolente di tutta la sinistra vicenda. Il razzismo è un’ideologia di massa; e le sue vittime non hanno né debbono avere un volto individuale e riconoscibile, sono anch’esse massa. Il dolore, così, non riguarda soltanto l’ingiustizia ma anche il crollo dei valori umanistici, la fine della parentesi individuale tra la barbarie primitiva e quella avvenire.”
Tra i tanti mali che oscurano l’orizzonte di questi nostri giorni c’è anche, e non è questo il luogo per indagarne cause e contorni, il risveglio dell’antisemitismo. Ed è in questo contesto che la scuola italiana si prepara a celebrare ancora una volta la Giornata della Memoria. Tanto si è fatto e sperimentato, in questi anni, tanto hanno dato, nella loro dolente disponibilità, i protagonisti diretti, i sopravvissuti dei lager. Eppure siamo costretti dalla forza delle cose a constatare che sottilissimo è lo strato di vernice steso a coprire l’antico marcio, che precarissime sono coscienza e memoria, fragilissime le conoscenze.
I due testi di cui si è tratteggiato qualche aspetto sono incisivi, letterariamente efficaci; sono memoria e riflessione; parlano di allora, di un fatto particolare, ma ne fanno pensiero sull’uomo e la sua vicenda, parlano di sempre e di oggi. E sono brevi. Possono essere letti integralmente in classe. Mentre contempliamo smarriti lo scarso profitto di un impegno che è stato intenso, come si diceva, vien da riflettere sul fatto che esso, pur vario negli strumenti e nei metodi, ha generalmente puntato su momenti che travalicassero i confini della classe, radunando platee numerose: masse di studenti, dunque, e possiamo limitarci a rimandare alle righe di Moravia testé citate. Allora vale forse la pena di calcare di nuovo l’antico sentiero, di tornare a inserire il cammino di una conoscenza che permanga abbastanza da divenire contenuto di coscienza in una trama di rapporti umani, dove ciascuno, interpellato personalmente, possa ascoltare il grido che il cuore immancabilmente emette di fronte alla riduzione spersonalizzante; possiamo forse rischiare di nuovo lo spazio di un’aula, il piccolo gruppo della classe in cui non si è massa, dove giocare la forza di una parola non massificata, di un pensiero non semplificato, con il tramite familiare della voce dell’insegnante.
A cura di:
Giuliana Zanello è nata a Milano nel 1957. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha insegnato al liceo classico di Busto Arsizio. Collabora occasionalmente con IlSussidiario.net