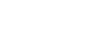MATERIALI PER L'INSEGNAMENTO - LETTERATURA
MEMORIALE, di Paolo Volponi - a cura di G.Zanello
MEMORIALE
Autore: Paolo Volponi
ed. Einaudi 2015, p 274, 11,40€
Di vite trascorse qui la brezza / è loquace per te?
Come potrebbe non esserlo, quando, svoltando a caso, ci si trova in una via deserta, ai lati muraglie forate da grandi finestre alte sulla strada, in mattoni ancora, alcune; in materiali compositi, cemento, metallo, vernici verdazzurre, molte altre; e intorno spettrale silenzio. Come non sentire una stretta, e un sapore cattivo in fondo alla gola, vedendo come ora siano niente più che degrado urbano quelle fabbriche dove tante generazioni di uomini e donne hanno consumato i loro giorni! La stessa pressione, la stessa densità di atmosfera abitata da una folla di fedi speranze mali e dolori che ci sorprendono in una chiesa pluricentenaria, lì tuttavia non nullificate, ma eternate da qualcosa di più forte della nostra fragile, eventualmente pietosa, memoria.
Ma la ‘loquacità’ del verso di Una visita in fabbrica di Sereni non rimanda solo al sentimento universale cui si è accennato. La domanda ha anche un risvolto specifico, relativamente al quale è forse ancora solo parzialmente evasa. Rimanda cioè alla necessità di trovare le parole per dire la fabbrica e, al di là della fabbrica, la società industriale, anzi, l’uomo della società industriale. Necessità che per la letteratura è dovere, essendo questa probabilmente la sua sola vera giustificazione, ovvero operare il riscatto che, attraverso la rappresentazione e la comprensione che ne deriva, restituisca all’uomo il suo posto adeguato, la sua adeguata statura.
Com’è noto, della questione della letteratura industriale a lungo si dibatté negli anni ’60 (la citata lirica di Sereni apparve su Menabò nel ’61). E se Vittorini lamentava l’attardato naturalismo delle rappresentazioni della vita di fabbrica, sempre a rischio di cadere in una nostalgia del passato priva di progettualità, altri sottolineavano l’inevitabilità dello scacco, essendo lo scrittore ordinariamente estraneo alla quotidianità operaia. Fu Franco Fortini, nel saggio Astuti come colombe, del ’62, a mettere a fuoco (nei termini di un’interpretazione strettamente marxistica) la questione di fondo, che potremmo articolare su due livelli. Il primo, ancora superficiale, consiste nel chiarire quanto vi sia di ingenuamente illusorio nel ritenere che lo scrittore, poiché non lavora in fabbrica, sia esterno rispetto al tema. Esterno egli può ritenersi solo in forza di una carenza di consapevolezza, che gli fa scambiare per estraneità le esteriori differenze assegnate alla sua funzione, in un mondo in cui la cultura si è nel frattempo trasformata in industria culturale. Ma a un secondo livello, più profondo, “Come si fa a parlare di industria e letteratura senza essere d’accordo almeno su questo (…): che cioè le forme, i modi, i tempi della produzione industriale e i suoi rapporti sono la forma stessa della vita sociale (…), sono né più né meno che l’inconscio sociale, cioè il vero inconscio, il mistero dei misteri”, mentre “non si spera e non si teme più di cercare, nella società che abbiamo tutt’intorno, l’anello che non tiene“ e “ognuno di noi è entrato a far parte dell’amalgama, della concrezione cementizia, del conglomerato. Dove passano la crepa, il solco, la spaccatura?”
In Memoriale (1962) Volponi passa per il disadattamento e la follia. Ad Albino Saluggia i fantasmi della mente impediscono l’adesione al mondo, se non, inizialmente, all’edificio stesso della fabbrica, immane ma semplice, nella sua razionalità, e alla macchina che risponde senza imprevisti ai suoi gesti, e alla stessa ripetitività del lavoro che, gli pare, lo lascia libero con se stesso, lontano dalle complicazioni e dal disordine delle relazioni umane. Ma è una breve illusione, perché presto la “cattiveria degli uomini” lo raggiunge nella veste dei medici di fabbrica, che insistono a volerlo curare della tisi che gli è stata diagnosticata. La fabbrica in cui Albino lavora, infatti, è moderna e perfino umana: gli operai ricevono assistenza medica, vengono pagati anche durante i periodi di malattia, possono approfittare di una casa- vacanze in montagna. Insomma, ingannerebbe chiunque. Ma non Albino, la cui logica stravolta in tutto legge una crudele macchinazione. Tutto, tutto è fatto per portarlo via da se stesso: dopo il collegio dell’infanzia, l’esercito, la prigionia, sono arrivati i medici con i loro controlli e le loro procedure e poi i lunghi soggiorni in sanatorio. Sono tutti contesti inautentici, tutti egualmente alienanti. E la fabbrica, sede dell’ultima crudele macchinazione, di questo mondo alienante, di questa “cattiveria degli uomini” è compiuta espressione.
“Così andava la mia giornata dietro la cassetta dei pezzi. Questo misurava il mio tempo e stabiliva con la sua luce diffusa su ogni pezzo della fabbrica, come in una visione, che dietro quelle cassette andava la mia stessa vita. C’erano molti che da vent’anni lavoravano allo stesso modo, ed erano ancora giovani. Il lavoro non era pesante, ma metteva addosso un tremito, per la lotta che si doveva fare con il tempo; non con quello della fabbrica ma con tutto il tempo, in generale. (…) Anche quelli che si lamentano dell’alto numero dei pezzi o del rumore o del caldo scrollano inutilmente la testa contro questi pretesti: la fatica era di usare tanto tempo nella fabbrica, nello stesso posto, nella inutilità del lavoro. Quelli che all’inizio mi sembravano i vantaggi della fabbrica a poco a poco erano diventati i suoi dolori.”
“Solo ora capisco che i problemi della paga oraria, del cottimo, del posto qui o là, contano relativamente poco e non sono quelli che dispongono della nostra vita nella fabbrica. L’importante è che le fabbriche, così come sono fatte oggi, annullano piano piano per tutti quelli che vi sono il sentimento di essere su questa terra, da solo e insieme agli altri e a tutte le cose della terra. Così si dimentica qual è il destino degli uomini e subentra un orgoglio sempre più profondo per l’organizzazione nella quale si è, per le macchine e per tutto l’ingranaggio che riesce a fare cose mai viste e pensate da un uomo. Addirittura ci si può spingere a pensare, con una certa convinzione, che gli uomini possono arrivare ad essere diversi persino nelle loro storie e nei loro sentimenti e ad avere conseguenze diverse da quelle di accontentarsi di vivere bene, tutti insieme e liberi. Ci si può spingere a pensare a un uomo non più fatto a somiglianza di Dio, nella sua terra, ma più somigliante e legato alle macchine, addirittura a una razza diversa. (…) Questo orgoglio prende gli uomini che nelle fabbriche hanno fortuna e stanno meglio; costoro sono alla fine più infelici. Vi sono invece altri che cadono, che non riescono a seguire l’industria, che lavorano con pena fino al momento in cui sono scacciati o fino alla ribellione; comunque meglio per loro che restano uomini.”
Che rapporto stabilire tra queste riflessioni di un protagonista paranoico e il pensiero dell’autore? Come si accennava, la malattia mentale di Albino Saluggia ha in primo luogo una funzione distanziante, come se proprio il suo disadattamento, in quanto non conseguente alla fabbrica ma preesistente, consentisse di vederla davvero, per come è, al riparo delle mistificazioni indotte dall’umana capacità di adattamento. Insomma, la deformazione che la malattia induce nel protagonista sarebbe comunque, nei confronti della realtà, lume più efficace della salute dei sani ben integrati. Nel contempo, Albino Saluggia è incapace di integrarsi anche in qualsivoglia organizzazione politica, il che mette l’autore al riparo da derive declamatorie. I sindacati sono quelli che si preoccupano della paga, del cottimo, dei mansionari: tutte cose che Saluggia ha scoperto essere poco importanti rispetto all’essenziale. La trovata, che potremmo forse definire sveviana, consente a Volponi di fare i conti anche con l’umanitarismo di industriali illuminati, qui rappresentato soprattutto dai medici, i peggiori nemici del protagonista, più profondamente intrusivi di tutti. Non c’è miglioramento che possa sanare il vero male, i progressi anzi lo aggravano. E qual è dunque il vero male? Qui è forse utile introdurre un elemento di prospettiva, ricordando come Simone Weil, a fronte della sua terribile esperienza di operaia alla Renault, avesse riassunto il male della fabbrica nella umiliazione; una umiliazione che attacca l’essere umano alla radice, degradandolo ai suoi stessi occhi nella più intima coscienza di sé; un’umiliazione immedicabile, da cui non si torna indietro. Il discorso di Saluggia rovescia queste conclusioni: nelle sue parole, il grande male è l’orgoglio. Siamo un passo ancora avanti. Per meglio funzionare, la società delle fabbriche ha incorporato la necessità di migliorare la condizione operaia. Così l’operaio è ora sottomesso non attraverso una autocoscienza umiliata, bensì attraverso l’orgoglio per la fabbrica, attraverso l’ammirazione per la macchina, sempre più straordinaria nelle sue realizzazioni, e per la perfetta organizzazione. Di fronte alla macchina e dentro l’organizzazione egli è nulla, essendo ridotto a nulla il valore di tutto ciò che compone la sua vita personale, ma può arrivare a sentirsi pieno d’orgoglio in quanto capace di stare al passo con le meravigliose macchine e con la meravigliosa organizzazione. Può arrivare al punto di sentirsi addirittura simile alle macchine.
L’umiliazione di cui parla Simone Weil è ancora un sentimento umano, per quanto doloroso, di un uomo che, nelle parole di Saluggia, è fatto a somiglianza di Dio; l’orgoglio di saper stare al passo coi ritmi frenetici della moderna innovazione è proprio di un essere totalmente alienato. E poco importa che sia o no un operaio, perché la società industriale si è ormai estesa a tutto quanto esiste al di fuori della fabbrica, ai sogni, ai desideri, ai sentimenti, alle ambizioni, dovunque si ritenga un valore stare al passo col progresso, organizzare, spezzettare per ottimizzare. Condizione dunque ben lontana dal risparmiare gli intellettuali. E’ il mondo in cui vali se funzioni, come le macchine, appunto, dove, e questo è l’arcanum imperii, la merce sei tu.
Oggi le fabbriche simili alla Renault di Simone Weil, come sappiamo, ci sono ancora, solo sottratte alla nostra vista quotidiana dalla remota lontananza dove sono fuggite. Ma la loro partenza non ci ha lasciato solo capannoni vuoti. Ci ha lasciato l’uomo orgoglioso di essere simile alla macchina, o disperato di non riuscire ad esserlo, in ogni caso la convinzione, più o meno esplicitata, che tra l’uomo e la macchina non vi sia differenza qualitativa e che il progresso non possa che insidiare e pian piano erodere il piccolo margine delle residue illusioni, svelandoci alfine come macchine, ma non delle più efficienti.
A cura di:
Giuliana Zanello è nata a Milano nel 1957. Si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore e ha insegnato al liceo classico di Busto Arsizio. Collabora occasionalmente con IlSussidiario.net